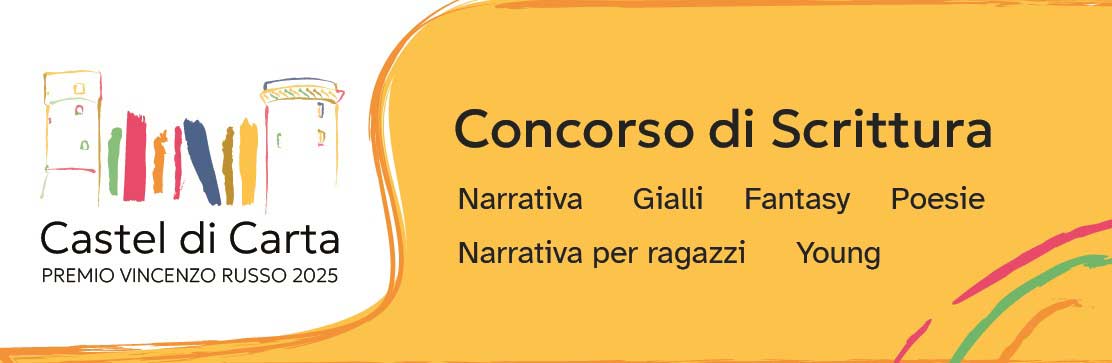Un mestiere ormai scomparso è quello del bottaio. Nel centro antico di Castellammare ce ne erano diversi con le loro botteghe. Altri lavoravano, dopo il 1783, data di fondazione del Regio Arsenale, per il naviglio da guerra ivi costruito.
In una città marinara e mercantile com’era Castellammare nei secoli passati, le botti servivano, oltre per contenere il vino per i vignaioli locali, anche per l’acqua e merce sfuse per le numerose navi sia militari e sia mercantili, specie quelle che dovevano affrontare lunghi viaggi oceanici.
Per queste ultime, le botti servivano anche e soprattutto per imbarcare acqua potabile e cioè l’Acqua della Madonna o Acqua dei navigatori. Quest’acqua, per le sue caratteristiche organolettiche, non produceva mucillagine ed altri sedimenti che, col tempo, la rendevano putrida ed imbevibile. Gli inglesi, per rendere potabile e un poco gradevole l’acqua nelle botti della loro flotta, preparavano un cocktail di ¾ d’acqua e ¼ di gin (grog).
A bordo, le botti erano adibite a contenere farina, legumi secchi, olio ed altro vettovagliamento: Per le navi militari anche i cartocci con polvere da sparo per la caricare le numerose bocche da fuoco. I bottai costruivano anche secchi o, meglio, secchie che avevano una forma tronco-conica a fondo convesso, con un manico curvo a semicerchio di metallo o di corda. Oltre a trasporre acqua o a sgottarla dalla sentina, vi erano secchie particolari dette “baie” con un fondo di diametro più largo e che servivano a contenere i tizzoni ardenti per accendere le micce dei cannoni.
Sia per uso civile e sia per quello militare, a Castellammare quindi si producevano migliaia di botti e di altri recipienti in legno. I bottai erano veri professionisti la cui arte si era tramandata da padre in figlio fin dall’epoca romana. I romani, infatti, abbandonato l’uso dei recipienti in terracotta (orci, anferre), specie per il vino optarono, fin dal I secolo d.C., per le botti. Plinio il Vecchio, nella sua Naturalia Historia (XVI,75) parla di “recipienti di legno rinforzati con cerchiature”.
I bottai quindi rappresentarono, per secoli, una ricca e potente corporazione tanto è vero che, a Castellammare, alla fine del XVI secolo, la loro Arciconfraternita costruì la chiesa dello Spirito Santo nei pressi di Fontana Grande. Una lapide con i simboli degli attrezzi del loro mestiere si trova in questa chiesa entrando sulla sinistra. In origine la lapide era collocata sul pavimento a copertura dell’accesso all’ipogeo dove i confratelli morti venivano collocati.
In tutte le chiese i morti erano sistemati su appositi sedili in pietra con fondo forato per essere “scolati” cioè soggetti alla naturale perdita del liquido corporeo accelerando il processo di mummificazione.
Ancora oggi per maledire qualcuno si dice: “Puozzo sculà!”. Mentre ‘o schiattamuorto era colui che, con un ferro acuminato, “schiattava”, forava le pance gonfie dei morti per favorire l’uscita dei liquidi corporei.
Ma come si costruivano le botti? Il legno usato poteva essere di castagno, ciliegio o rovere ma a Castellammare si usava principalmente il castagno per la facile reperibilità sui boschi di Quisisana.
Il castagno, legno abbastanza duro, ma elastico e di facile lavorazione, appena segato si presenta bianco, ma diventa presto scuro assumendo un colore nocciola.
Le fasce verticali che compongono la botte si chiamano doghe. Esse, curvate mediante un prolungato bagno in acqua bollente erano sistemate in piega sotto un torchio.
Per assemblare le toghe, si faceva ricorso a cerchi di sostegno provvisori e, una volta montata ed imbastita la botte, si scavava il “caprugginato” ai due estremi, nella parte interna.
Una scanalatura, la capruggine, era destinata ad ospitare il bordo dei fondi. Alle due estremità si sistemavano cerchi di ferro che venivano scaldati sul fuoco per dilatarli in più possibile in modo che il successivo raffreddamento potesse ben ammorsare tutte le assi di legno. Fin agli anni ’60 del secolo scorso, nella vasca antistante la sorgente di Fontana Grande, venivano messe in ammollo le ruote cerchiate delle carrette e delle carrozzelle per ammorsare il perimetrale cerchio di ferro sulla ruota in legno.
Bottai specializzati costruivano piccole botti dette barrique (‘o varrille) per contenere vino pregiato. Il legno usato era il rovere che rilasciava tannini più fine ed altre essenze per aromatizzare il vino. La loro capacità non superava i 225 litri.
AdBlock Detected!
Il nostro sito web è reso possibile dalla visualizzazione di annunci pubblicitari ai nostri visitatori. Sostienici,
disattiva l’Ad-Block.